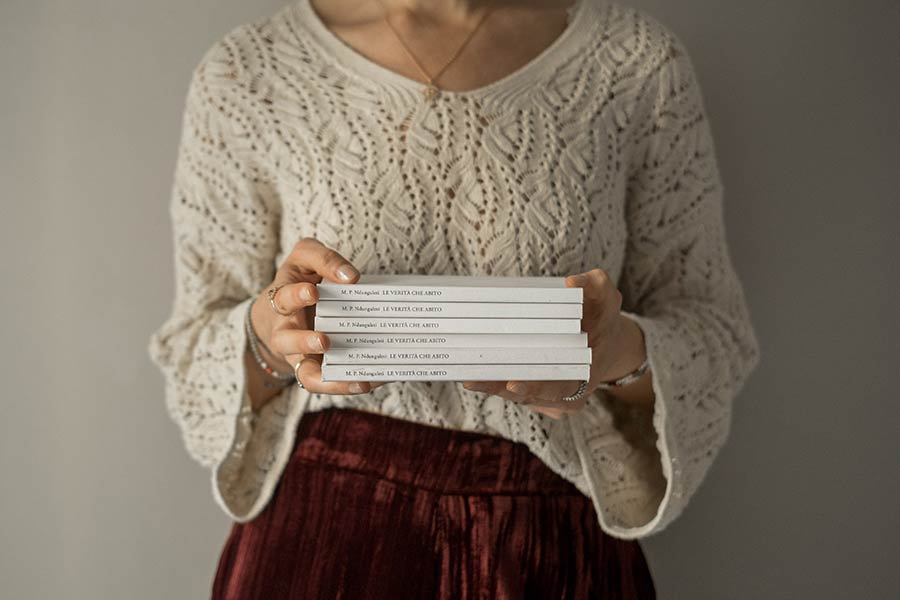L’attaccamento sicuro è molto più di un concetto teorico: è la base invisibile, ma potentissima, delle nostre relazioni e del nostro benessere psico-fisico.
Il mio interesse per questa tematica non nasce solo dalla mia formazione professionale, ma affonda le radici nella mia esperienza personale, fin dall’adolescenza.
Ricordo che già durante le scuole medie, ero profondamente affascinata da questa tematica e cercavo risposte tra le pagine di libri di psicologia per comprendere meglio la mia storia familiare, allora difficile da decifrare e capace di lasciarmi, in quel periodo, molte domande aperte.
Quel bisogno di capire è diventato, nel tempo, una direzione chiara e sentita, che ha plasmato sia la mia crescita personale sia il mio percorso formativo e professionale.
Oggi, a distanza di più di trent’anni, nel nostro Frame Studio Psicologia accompagniamo con cura il lavoro di prevenzione e sostegno all’attaccamento sicuro, sia con famiglie di bambini neurotipici che neurodivergenti.
In particolare, ci occupiamo di accompagnare genitori, educatori e professionisti nel promuovere un attaccamento sicuro anche nei contesti di neurodivergenze.
Il nostro approccio integra teoria dell’attaccamento, neurobiologia e attenzione alla dimensione sensoriale e comunicativa del bambino e delle persone, offrendo strumenti personalizzati per sostenere il legame di attaccamento in modo efficace e rispettoso.
All’interno dei nostri percorsi in Frame Hub abbiamo a cuore il benessere corpo-mente-energia psicofisica di ogni età e di ogni tipo di corpo e mente, neurotipica e neurodivergente.
Con questo articolo desidero offrirti uno sguardo semplice ma approfondito, tra rigore scientifico e vissuto autentico, per comprendere cos’è l’attaccamento sicuro e perché può essere così trasformativo — per la nostra salute, per la qualità della nostra vita, di chi ci sta accanto e delle generazioni successive.
Cos’è l’attaccamento sicuro?

Gli studi sull’attaccamento
L’attaccamento è un legame istintivo, emotivo e biologico primario tra il bambino e le figure di riferimento, un vincolo fondamentale che ha radici profonde nella nostra natura di mammiferi (Bowlby, 1969).
Come esseri umani, siamo biologicamente programmati per cercare protezione, contatto e connessione: non si tratta solo di emozioni, ma di un sistema innato di sopravvivenza, condiviso con altre specie.
Le neuroscienze affettive ci mostrano come il bisogno di attaccamento sia iscritto nel nostro sistema nervoso autonomo: il nostro corpo riconosce la sicurezza relazionale come base per la regolazione emotiva, la crescita e l’apprendimento.
L’attaccamento non è quindi solo una dinamica psicologica, ma una funzione biologica profonda, che ci accompagna per tutta la vita.
Studi più recenti, come quelli di Daniel Siegel e Allan Schore, mettono in luce come le esperienze relazionali precoci influenzino profondamente lo sviluppo delle aree cerebrali coinvolte nella regolazione affettiva, nella gestione dello stress e nella capacità di entrare in relazione con l’altro (Siegel, 2012; Schore, 2019). In particolare, le interazioni di attaccamento possono favorire l’integrazione tra le diverse aree del cervello, promuovendo un funzionamento armonico tra sistemi cognitivi, emotivi e corporei.
Infine, grazie alla prospettiva di Deb Dana, sappiamo che la sicurezza relazionale si intreccia strettamente con il nostro sistema nervoso autonomo.
È attraverso le connessioni sicure che il corpo “impara” a sentirsi al sicuro, attivando la cosiddetta neurocezione di sicurezza, una condizione fondamentale per costruire relazioni sane e stabili (D. Dana, 2020; S. Porges, 2018).
Questa è una chiave preziosa anche per chi lavora con il corpo: ad esempio, per osteopati e osteopati pediatrici, comprendere la neurocezione significa prestare attenzione non solo alle tecniche manuali, ma al modo in cui si tocca, si guarda, si respira accanto alla persona trattata e al suo stile di attaccamento.
È proprio questa dimensione affettiva, non verbale e profondamente corporea, che può fare la differenza nel facilitare una risposta di regolazione e fiducia nel sistema nervoso delle persone, soprattutto nei bambini.
In altre parole, la qualità della presenza corporea dell’adulto può diventare un potente stimolo regolativo per il bambino, proprio perché il corpo percepisce prima ancora di capire.
Cosa rende un attaccamento sicuro?

Nel mio lavoro quotidiano, da quasi vent’anni, riscontro spesso che la sicurezza affettiva non dipende dalla perfezione, ma dalla coerenza, dalla qualità della presenza emotiva e dalla capacità di saper riparare le rotture.
Un attaccamento sicuro si struttura quando un bambino percepisce, anche a livello corporeo, che l’adulto è disponibile, affidabile, e capace di accogliere i suoi stati corporei, cognitivi ed emotivi.
Questo gli permette di rilassarsi, esplorare il mondo, tornare e sentirsi accolto/a ogni volta.
Come insegna il Circolo della Sicurezza– Circle of Security–Parenting (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin, 2016), approccio su cui ho ricevuto una formazione specifica e che integro nel mio lavoro, i bambini hanno bisogno di due pilastri fondamentali: una base sicura da cui partire e un porto sicuro a cui tornare.
Il ruolo del caregiver è “tenere aperto il cerchio”, cioè accompagnare il/la bambino/a nell’esplorazione del mondo e accoglierlo/a quando ha bisogno di conforto.
Questo movimento naturale tra autonomia e connessione è regolato sia dalle emozioni che dal sistema nervoso autonomo. Quando il bambino riceve risposte sensibili e sintonizzate, il suo corpo impara a riconoscere la sicurezza.
Si calma più facilmente, gioca con curiosità, e sviluppa un senso profondo di fiducia nelle relazioni e in sé stesso.
Non è solo psicologia: è corpo, istinto e neurobiologia in azione.
I comportamenti tipici dei bambini con attaccamento sicuro

Riconoscere un attaccamento sicuro nel bambino è possibile osservando il modo in cui si relaziona con le figure di riferimento e con l’ambiente.
Si tratta di comportamenti semplici ma profondamente significativi, che riflettono un sistema affettivo ben regolato e un senso di fiducia interiorizzato.
Ecco alcuni segnali chiari:
- Il bambino cerca attivamente conforto nei momenti di disagio o paura, perché ha imparato che l’adulto risponde in modo coerente e rassicurante.
- Si calma con facilità quando riceve attenzione emotiva e contatto: la presenza dell’adulto ha un effetto regolativo diretto sul suo sistema nervoso.
- Esplora il mondo con curiosità e autonomia, sapendo di poter contare su una base sicura a cui tornare in caso di bisogno.
Dal punto di vista neurobiologico, questi comportamenti indicano un sistema nervoso autonomo che si sente “al sicuro” e può funzionare in modalità di apertura e apprendimento.
Come ci mostrano le teorie dell’attaccamento e regolazione emotiva, il bambino con un legame di attaccamento sicuro non solo gestisce meglio lo stress, ma costruisce anche relazioni più stabili nel tempo.
Noi crediamo profondamente che allenarsi ad osservare questi segnali sia fondamentale anche per chi lavora nell’ambito educativo o corporeo (osteopati, osteopati pediatrici, nutrizionisti, medici, pediatri, ecc..), perché spesso il corpo racconta la storia dell’accudimento e dell’ attaccamento prima ancora che le parole lo facciano.
Gli altri stili di attaccamento: insicuro, evitante, ambivalente, disorganizzato
Breve panoramica dei 4 stili di attaccamento insicuro

Non tutti i bambini sviluppano un attaccamento sicuro. Quando la relazione con il caregiver non è sufficientemente prevedibile, sintonizzata o contenitiva, possono emergere diverse forme di attaccamento insicuro. Questi stili rappresentano tentativi di adattamento del bambino a contesti affettivi percepiti come incoerenti, imprevedibili o dolorosi.
1. Stile evitante
Il bambino con attaccamento evitante tende a minimizzare i propri bisogni affettivi. Non cerca attivamente conforto e può sembrare molto indipendente e autonomo, anche in situazioni di stress. Questo stile si sviluppa quando le richieste emotive non trovano risposta o vengono regolarmente ignorate.
2. Stile ambivalente (o resistente)
Qui il bambino appare costantemente in allerta: ricerca la vicinanza ma fatica a sentirsi davvero rassicurato. Le sue reazioni possono sembrare “esagerate”, ma in realtà riflettono una profonda incertezza sulla disponibilità dell’adulto.
3. Stile disorganizzato
Il più complesso tra gli stili di attaccamento insicuro. Il bambino mostra comportamenti contraddittori, a volte bloccati o caotici. Questo stile è spesso associato a esperienze relazionali traumatiche o altamente disorientanti. Il caregiver può essere percepito sia come fonte di conforto sia come fonte di paura.
Come si manifestano e cosa li differenzia
Questi stili di attaccamento si riflettono nei comportamenti quotidiani del bambino:
- evitamento del contatto affettivo;
- iperattivazione emotiva o ansia da separazione;
- difficoltà nella regolazione emotiva e nel gioco libero;
- segnali di confusione, ritiro o ambivalenza relazionale.
Ogni stile è il risultato di un adattamento al contesto relazionale. Il bambino non sceglie consapevolmente come comportarsi: si organizza emotivamente per proteggersi e sopravvivere nel suo ambiente.
Effetti a lungo termine sul comportamento e sulle relazioni
Gli effetti dell’attaccamento insicuro possono estendersi nel tempo, influenzando la vita adulta:
- difficoltà a fidarsi degli altri;
- relazioni instabili o troppo dipendenti;
- bassa autostima;
- difficoltà nella gestione dei conflitti o nell’espressione delle emozioni.
Tuttavia, è importante ricordare che questi modelli di attaccamento non sono una condanna: sono pattern appresi, e come tali, possono essere compresi, trasformati e riparati con nuove esperienze relazionali sicure, supporto professionale e consapevolezza.
Come si sviluppa l’attaccamento sicuro nei bambini?

Lo sviluppo di un attaccamento sicuro nel bambino è un processo profondo e delicato, che si costruisce nel tempo attraverso interazioni ed esperienze quotidiane ripetute.
Non servono gesti straordinari, ma una presenza coerente, empatica e sintonizzata ripetuta nel tempo.
Il ruolo della figura di accudimento:sintonizzazione, empatia, presenza
La qualità della relazione tra genitore (o caregiver) e bambino è il fattore centrale. Quando l’adulto è emotivamente disponibile, risponde con attenzione ai segnali del bambino, lo accoglie senza giudizio e si adatta ai suoi ritmi, si crea uno spazio in cui il sistema nervoso del bambino può rilassarsi e organizzarsi (Siegel, 2021).
La sintonizzazione affettiva non è solo comprendere ciò che il bambino dice, ma cogliere e rispondere ai suoi bisogni anche non verbali: sguardi, pianto, tono del corpo.
Questo è il terreno in cui nasce la fiducia di base, fondamento del legame di attaccamento.
L’importanza della co-regolazione emotiva nei primi anni di vita
Nei primi anni di vita, il bambino non è ancora in grado di regolare da solo le proprie emozioni. È grazie alla co-regolazione – cioè al fatto che l’adulto lo accompagna nella tempesta emotiva – che il suo sistema nervoso impara a calmarsi.
Studi recenti evidenziano come le esperienze ripetute di regolazione condivisa favoriscano lo sviluppo di reti cerebrali integrate e la maturazione della corteccia prefrontale, sede della regolazione emotiva, dell’empatia e della funzione riflessiva (Schore, 2019; Feldman, 2020). Il contatto caldo e la presenza calma dell’adulto non sono solo rassicuranti: sono organizzatori neurologici.
Attaccamento e costruzione dell’identità
Il modo in cui veniamo accolti fin da piccoli contribuisce a modellare la nostra identità. Il bambino con attaccamento sicuro cresce sentendosi visto, valido e degno di amore: questo diventa il suo “specchio interno”.
Come conferma la teoria dell’interocezione e la visione di autori come Allan Schore (2019), la sicurezza relazionale non solo forma l’immagine di sé, ma contribuisce alla coerenza tra esperienza emotiva, percezione corporea e sviluppo cognitivo.
Quando il legame di attaccamento è sicuro, il bambino non solo si sente al sicuro: diventa sicuro.
Questo ha un impatto duraturo su tutto il suo sviluppo emotivo, neurobiologico, corporeo e relazionale.
Attaccamento e vita adulta: quando il passato ci accompagna

L’attaccamento sicuro o insicuro, che si sviluppa a partire dai primi mesi e anni di vita, non rimane confinato all’infanzia. Anche se a volte potremmo non rendercene conto, influisce profondamente su come ci relazioniamo da adulti: nel modo in cui stabiliamo legami, viviamo l’intimità, affrontiamo i conflitti e percepiamo il nostro valore personale.
Come lo stile di attaccamento infantile influisce su relazioni, autostima e gestione dei conflitti
Uno stile di attaccamento insicuro può tradursi in difficoltà a fidarsi, paura dell’abbandono, ipercontrollo, evitamento delle emozioni o bisogno costante di rassicurazioni.
Tutto questo può compromettere la qualità delle relazioni, la capacità di gestire i conflitti in modo sano e la percezione del proprio valore.
Chi ha interiorizzato un attaccamento sicuro, invece, tende ad avere una buona regolazione emotiva e una buona gestione dello stress, una visione stabile di sé e degli altri, ed è capace di costruire relazioni affettive fondate su fiducia, reciprocità e autonomia.
Attaccamento adulto e stili relazionali

Anche da adulti, possiamo identificare diversi stili relazionali che riflettono i modelli interiorizzati nell’infanzia:
- Stile sicuro: apertura emotiva, gestione sana della distanza e del bisogno, fiducia.
- Stile ansioso: timore di essere abbandonati, bisogno costante di conferme, iperattivazione.
- Stile evitante: difficoltà a mostrarsi vulnerabili, eccessiva autonomia, distacco emotivo.
- Stile disorganizzato: comportamenti relazionali contraddittori, tendenza al caos o alla chiusura.
Questi stili non sono etichette fisse: sono mappe affettive apprese, che possiamo rendere più flessibili con consapevolezza e nuove esperienze.
È possibile “riparare” un attaccamento insicuro?
Assolutamente sì. L’attaccamento non è un destino immutabile. Anche da adulti, possiamo modificare il nostro stile di attaccamento attraverso relazioni correttive, esperienze affettive sicure e percorsi esperienziali e terapeutici che facilitino l’integrazione tra emozioni, pensieri e corpo.
Grazie alla neuroplasticità, il cervello adulto ha la capacità di riorganizzarsi: possiamo imparare a regolare meglio le emozioni, riconoscere i nostri bisogni più profondi e sviluppare forme più sicure di connessione con gli altri e con noi stessi.
In ambito clinico si parla di “sicurezza guadagnata” (earned security), una forma di attaccamento sicuro che si sviluppa in età adulta in seguito a esperienze di cura, consapevolezza e riparazione emotiva, anche se il proprio attaccamento originario era insicuro (Zaccagnino, 2022).
Questo processo richiede tempo, fiducia e la possibilità di essere visti in modo nuovo, all’interno di relazioni significative.
Come ricorda anche il modello del Circle of Security-Parenting, l’importante non è la perfezione, ma la capacità di “riparare” con consapevolezza. Ogni momento di relazione – anche quelli difficili – può diventare un’occasione concreta di crescita, riorganizzazione e trasformazione affettiva.

Come promuovere un attaccamento sicuro con i propri figli
Favorire un attaccamento sicuro nella relazione genitore-bambino non richiede perfezione, ma una presenza coerente, empatica e sufficientemente stabile.
Ogni giorno, attraverso piccoli gesti e scelte quotidiane, è possibile creare uno spazio relazionale in cui il bambino si senta visto, accolto e contenuto.
L’importanza della presenza emotiva (non solo fisica)
Essere presenti non significa soltanto “esserci” fisicamente.
Ciò che costruisce sicurezza è la presenza emotiva: uno sguardo che accoglie, una voce che calma, un atteggiamento che comunica al bambino “sono qui con te, ti capisco”. È questo tipo di vicinanza affettiva che aiuta il bambino a organizzare il suo mondo interno e a sviluppare un legame di attaccamento sano e stabile.
L’ascolto, la validazione emotiva, il contatto
Promuovere un attaccamento sicuro significa anche ascoltare davvero, senza fretta né giudizio. Significa dare un nome alle emozioni e comunicarne la legittimità: “Capisco che sei arrabbiato”, “È normale sentirsi spaventati”. La validazione emotiva è uno degli strumenti più potenti per sostenere la regolazione emotiva del bambino.
Gestire la frustrazione e dare sicurezza senza iperprotezione
Una parte fondamentale dell’attaccamento sicuro è aiutare il bambino a tollerare piccole frustrazioni in un contesto protetto. Essere un porto sicuro non significa evitare ogni difficoltà, ma sostenere il bambino nel viverla con fiducia, sapendo di non essere solo.
L’iperprotezione, seppur mossa da buone intenzioni, può ostacolare lo sviluppo dell’autonomia e della resilienza emotiva tanto quanto l’assenza di protezione.
In sintesi, favorire un attaccamento sicuro significa essere una base solida da cui partire e un rifugio sicuro a cui tornare, rispettando i tempi, i bisogni e l’unicità di ogni bambino.

Epigenetica e attaccamento: il legame invisibile tra mente e biologia
Negli ultimi anni, le ricerche nel campo dell’epigenetica e dell’attaccamento hanno portato a una scoperta fondamentale: il modo in cui veniamo accuditi nei primi anni di vita non influenza solo il nostro mondo emotivo, ma lascia tracce anche a livello biologico.
Il legame genitori-figli influenza non solo lo sviluppo psicologico ma anche quello biologico
Le esperienze di cura affettuosa – così come quelle di trascuratezza o stress precoce – modificano l’espressione dei nostri geni, senza alterare il DNA.
Questi cambiamenti epigenetici influenzano funzioni vitali come la regolazione dello stress, lo sviluppo del sistema immunitario, la crescita cerebrale e le capacità di autoregolazione emotiva (Meaney, 2010; Champagne, 2020).
Il corpo del bambino, attraverso il sistema nervoso, “registra” se l’ambiente è sicuro o minaccioso, e si adatta di conseguenza. Per questo, l’attaccamento sicuro non è solo una base affettiva: è una forma concreta di protezione biologica.
Le esperienze di cura affettuosa o di trascuratezza lasciano impronte epigenetiche: regolazione dello stress, sistema immunitario, sviluppo cerebrale
Le relazioni precoci, soprattutto quelle con le figure di accudimento, non influenzano solo il benessere emotivo del bambino, ma hanno un impatto diretto anche sul suo sviluppo biologico. Le esperienze di cura affettuosa, presenza sensibile e contatto rassicurante attivano nel bambino circuiti di sicurezza, aiutandolo a sviluppare una buona regolazione dello stress, un sistema immunitario più resiliente e un cervello capace di autoregolarsi.
Al contrario, condizioni di trascuratezza, disconnessione emotiva o stress relazionale prolungato possono modificare l’espressione genica attraverso meccanismi epigenetici. Queste “impronte” non cambiano il DNA, ma influiscono su come i geni si attivano o si disattivano: è così che l’ambiente affettivo “scrive” nel corpo del bambino.
Tutto ciò conferma quanto sia fondamentale promuovere relazioni genitore-bambino basate su un attaccamento sicuro, soprattutto nei primi anni di vita, quando il cervello è altamente plastico e sensibile alle esperienze relazionali.
L’attaccamento sicuro come “protezione epigenetica”: cosa dicono gli studi

Studi longitudinali confermano che i bambini cresciuti in ambienti affettivamente stabili e sintonizzati mostrano una maggiore resilienza allo stress, una regolazione più efficace del sistema nervoso autonomo e minori marcatori biologici di infiammazione in età adulta (Gunnar & Quevedo, 2007; Narvaez et al., 2019).
Al contrario, esperienze prolungate di disconnessione emotiva, trascuratezza o trauma relazionale precoce possono lasciare impronte epigenetiche negative, che aumentano il rischio di vulnerabilità psico-fisica e di trasmissione intergenerazionale del disagio (Zhang et al., 2022).
L’epigenoma è plastico e modificabile: nuove esperienze relazionali, ambienti sicuri, e percorsi di cura affettiva possono “riscrivere” le tracce lasciate dalle esperienze precoci, restituendo flessibilità biologica e benessere a lungo termine.
Per questo, promuovere un attaccamento sicuro nei primi anni di vita è uno degli interventi più potenti anche a livello di prevenzione della salute globale.
Traumi precoci e attaccamento disorganizzato: trasmissione intergenerazionale del disagio
Quando il bambino sperimenta traumi precoci, come trascuratezza, abbandono emotivo, o esperienze affettive caotiche, può sviluppare un attaccamento disorganizzato. In questo stile, la figura di riferimento – che dovrebbe offrire protezione – è anche fonte di paura o imprevedibilità. Il sistema nervoso del bambino si trova in conflitto: cerca vicinanza, ma la teme allo stesso tempo.
Questa condizione crea uno stato di allerta costante e compromette la capacità di regolazione emotiva, con effetti che possono durare nel tempo. Senza un intervento correttivo, il bambino rischia di crescere con modelli relazionali confusi, instabili o iperattivati.
Il rischio, evidenziato da numerosi studi, è che questi schemi si trasmettano da una generazione all’altra, influenzando il modo in cui un adulto si relaziona poi con i propri figli. È ciò che viene definito trasmissione intergenerazionale del disagio: il passato che si ripete, se non viene riconosciuto, compreso e trasformato.
La buona notizia è che anche l’attaccamento disorganizzato può essere rielaborato. Attraverso esperienze affettive riparative, supporti psicoterapeutici e relazioni significative, è possibile interrompere il ciclo del trauma e offrire ai bambini nuove possibilità di sicurezza.
Creare sicurezza è un dono per il futuro

L’attaccamento non è solo una teoria, né solo una questione che riguarda l’infanzia.
È una lente attraverso cui possiamo leggere — e riscrivere — le nostre relazioni, il nostro modo di essere al mondo. È un filo invisibile che collega il corpo, le emozioni e la mente, dall’inizio della vita fino all’età adulta.
Un attaccamento sicuro è molto più di un “buon inizio”: è una forma di prevenzione, un fattore protettivo profondo per la salute psicofisica, per la capacità di creare legami sani, per affrontare le sfide della vita con fiducia.
A volte mi fermo a pensare a quanto ogni gesto affettuoso, ogni presenza stabile, ogni emozione accolta possa fare la differenza. Anche piccole riparazioni quotidiane — un abbraccio dato con intenzione, un “ti vedo” sincero, un momento di silenzio condiviso — sono semi di cura e trasformazione.
E se non abbiamo potuto vivere un attaccamento sicuro da piccoli?
Non è mai troppo tardi. Grazie alla consapevolezza, alle relazioni significative e alla possibilità di chiedere supporto, è possibile trasformare il proprio stile di attaccamento anche in età adulta.
E tu? Qual è il tuo rapporto con la sicurezza emotiva? Ti sei mai chiesto/a che impatto ha avuto il tuo stile di attaccamento nelle relazioni?
Puoi raccontarcelo scrivendoci una mail e condividere l’articolo con chi pensi possa beneficiarne.
Crediamo davvero che ogni riflessione, ogni condivisione, sia un passo importante verso un modo nuovo di stare e vivere nel mondo, con noi stessi e con gli altri.
Fonti di questo articolo
- Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books
- Siegel, D. J. (2012). The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are. New York: Guilford Press
- Schore, A. N. (2019). The Development of the Unconscious Mind. New York: Norton
- Dana, D. (2020). The Polyvagal Theory in Therapy: Engaging the Rhythm of Regulation. New York: Norton
- Porges, S. W. (2018). Clinical Applications of the Polyvagal Theory: The Emergence of Polyvagal-Informed Therapies. New York: Norton
- Powell, B., Cooper, G., Hoffman, K., Marvin, R. (2016). Il Circolo della Sicurezza. Guida per i genitori. Firenze: Giunti Psychometrics